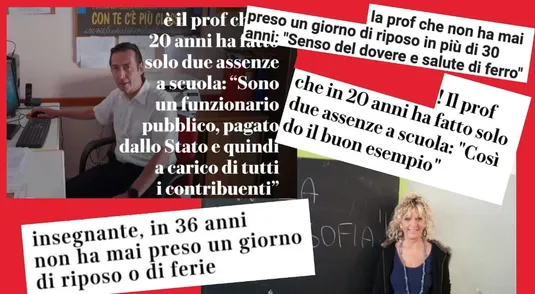Cacciati, su due piedi, giusto in tempo prima dell’arrivo del decreto “Cura Italia”, che ha bloccato i licenziamenti per causa oggettiva. «Non è un caso isolato - commenta con L’Espresso Ivana Veronese, segretaria confederale Uil - abbiamo avuto tante segnalazioni di questo tipo, che ovviamente abbiamo impugnato. Alcuni imprenditori hanno agito velocemente, all’inizio dell’emergenza, subito dopo il caso di Codogno, prima dell’arrivo del decreto Cura Italia che ha bloccato i licenziamenti».
La pandemia - in Italia, come nel resto d’Europa - ha vittime secondarie ancora non contabilizzate fino in fondo. Centinaia di migliaia di persone rimaste senza un lavoro o con redditi quasi dimezzati. Pronti ad entrare nell’area silenziosa, spesso invisibile, della povertà estrema.
Il blocco dei licenziamenti - prorogato fino al 17 agosto - ha probabilmente evitato i danni peggiori, anche se momentaneamente. Quella diga legislativa, però, non ha tenuto fino in fondo. Dimissioni volontarie - a volte forzate -, risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro, fino a casi, che sfiorano l’assurdo, di “sospensioni” da lavoro e stipendio. Un limbo, questo, che ha colpito, ad esempio, le lavoratrici delle mense scolastiche comunali di Roma.
LE DONNE, PRIME VITTIME
Sabrina Vannozzi, romana, è una delle addette alle mense scolastiche della capitale. Quindici aziende con appalti del Campidoglio, per circa 3.000 addetti. «È un lavoro importante - racconta, con un pizzico di orgoglio, Sabrina - noi siamo prima di tutto mamme. Ci sono bambini che fanno un solo pasto a mensa, ci sono situazioni difficili, ci chiedono il bis, perché ci dicono che a casa non c’è da mangiare. A scuola i bambini imparano a mangiare bene, spesso a casa hanno pasti veloci».
Con la chiusura delle scuole quel servizio si è fermato. Gran parte dei lavoratori ha contratti part-time, con uno stipendio di circa 750 euro al mese: «Con il lockdown siamo state messe tutte in cassa integrazione - spiega la lavoratrice - il che vuol dire, nel mio caso, prendere 430 euro». Soldi, che in molti casi, non sono mai arrivati.
La gran parte delle aziende ha scelto di non anticipare gli ammortizzatori sociali, scaricando l’onere sull’Inps. E l’istituto, come è ormai noto, è andato in tilt, accumulando ritardi nei pagamenti. In questo caso, però, la situazione è ancora più drammatica. Il contratto multiservizi che regola il lavoro delle addette alle mense prevede la sospensione dallo stipendio nel periodo della chiusura delle scuole. Si entra in un limbo, dove formalmente rimani dipendente, ma con busta paga pari a zero. «Non puoi accedere alla Naspi (l’indennità di disoccupazione), semplicemente da fino giugno a metà settembre non prendi nulla», racconta Sabrina. Che aggiunge: «Ora stiamo chiedendo che almeno quest’anno ci possa essere un sostegno al reddito per il periodo estivo».
Le donne sono state tra le prime vittime della strage di lavoro. «Abbiamo avuto casi di dimissioni incentivate di lavoratrici madre - racconta Roberto Iovino, segretario generale della Cgil del Lazio -; sono riuscite ad accedere alla Naspi perché il figlio ha meno di un anno di età, ma ora sono fuori dal mercato del lavoro». Uscire ora dal mondo dell’impiego significa rischiare una disoccupazione difficile da risolvere.
LE DIMISSIONI FORZATE
La selva normativa del mondo del lavoro in Italia è piena di dettagli dove si nasconde il diavolo. Se il blocco dei licenziamenti ha evitato, almeno per ora, i danni peggiori, alcune aziende non si sono date per vinte. L’importante era abbattere il costo della manodopera. I lavoratori più colpiti sono i precari, assunti con contratti a termine.
L’osservatorio dell’Inps nell’ultimo rapporto pubblicato qualche giorno fa ha evidenziato un saldo negativo di 359 mila contratti non rinnovati nel solo mese di marzo. Un trend (a febbraio la flessione è stata di 253 mila posti di lavoro a tempo determinato scaduti e non confermati) che aggrava una situazione già difficile per questo tipo di rapporti di lavoro. E ritrovare un impiego può richiedere tempi lunghissimi: le assunzioni, nel primo trimestre 2020, si sono contratte del 24%, mentre sono diminuite del 26% le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato. E a marzo eravamo solo all’inizio.
Nonostante il “Cura Italia” i licenziamenti - anche se diminuiti, per effetto del blocco - non si sono fermati. C’è un’area grigia, difficile da intercettare, che spesso sfugge anche ai sindacati. Dietro alcune dimissioni volontarie o concordate - non vietate dai decreti Covid - si sono nascoste pressioni da parte delle imprese o abbandoni del posto di lavoro per una situazione economica divenuta insostenibile. Molti di questi accordi non hanno visto l’intervento delle parti sociali e sono passati attraverso le “Commissioni di certificazione” dal 2010 competenti anche in tema di lavoro. In sostanza sono sedi private che mediano tra lavoratore ed impresa; nei fatti gli accordi vengono presi prima all’interno dell’azienda e semplicemente “certificati”. Il tutto lontano dai sindacati.
Tra i racconti che L’Espresso ha raccolto ci sono, ad esempio, storie di giovani lavoratori invitati dall’azienda a presentare le proprie dimissioni lo scorso maggio, con la giustificazione di commesse non più arrivate. Niente cassa integrazione - per motivi a volte di semplice immagine dell’azienda, che non voleva apparire in crisi - un bonus di 2 o 3 mensilità e la porta d’uscita aperta davanti a se. Soluzioni che piacciono particolarmente alle imprese, tanto che il sito della “Commissione di certificazione” dell’Università di Roma 3 le indica apertamente, nella parte dei sito sulla “Emergenza Covid”. E aggiunge un dettaglio non trascurabile: è sempre possibile certificare anche un licenziamento per giusta causa oggettiva - vietato dal governo fino al prossimo agosto - perché l’eventuale inefficacia può essere evitata attraverso un accordo tra le parti: «La transazione relativa a tale controversia può certamente avvenire nelle sedi previste (…) compresa quella della Commissione di certificazione». Basta mettersi d’accordo, in fondo. Come? Proprio a causa del Covid il tutto avviene in via telematica e, almeno in alcuni casi, il lavoratore si collega dalla stessa azienda, magari con il manager che lo vuole fuori a qualche scrivania di distanza.
L’Espresso ha provato a contattare quattro Commissioni di certificazione (università Roma 3, il consorzio Uniprof di Tor Vergata, la Università telematica Marconi e l’Università Mercatorum), chiedendo dati e informazioni sulle procedure di risoluzione dei contratti di lavoro durante il Covid. Nessuno ha risposto alle domande.
CRISI CAPITALE
Roma rischia di precipitare in una crisi economica e sociale senza precedenti. È la città dove si concentrano maggiormente i settori colpiti dalle conseguenze del lockdown. Al netto del pubblico impiego, l’economia si basa essenzialmente sul turismo, sul commercio, sullo spettacolo e sui servizi. E anche in questo caso la fine dei rapporti di lavoro, attraverso dimissioni più o meno volontarie, è il sintomo più preoccupante. Tanti stanno gettando la spugna. «Pensiamo ai camerieri dei locali del centro storico, o dell’Eur - spiega Roberto Iovino, Cgil Lazio -. Molto spesso hanno contratti part-time, con circa 750 euro netti un busta paga. È una cifra che riescono ad integrare con le mance». Vivere a Roma è caro. Un affitto, anche di una sola stanza, può costare 400-500 euro al mese. Con il lockdown questi lavoratori sono andati praticamente tutti in cassa integrazione: «Il che vuol dire, per loro, prendere poco più di 400 euro al mese». E ovviamente nessuna mancia. Chi era arrivato nella capitale dal sud Italia per cercare un lavoro - come moltissimi lavoratori della ristorazione - alla fine ha preferito dimettersi, tornando verso casa. Riprendere il lavoro di prima, con un settore che ancora soffre, ora sarà difficilissimo.
La perdita dell’impiego è stata una delle conseguenze silenziose dell’osannato “smart working”. Grandi aziende, ministeri, uffici pubblici della capitale si sono svuotati. Tutti a casa, a lavorare davanti ad un computer. Le mense aziendali hanno chiuso i battenti, i servizi di pulizia e manutenzione sono diminuiti. È un intero settore dell’indotto che si è fermato, mettendo tutti in cassa integrazione. Ma non sempre è stato possibile. Alcune società che erano in difficoltà economica, con forti problemi di debiti prima del lockdown, si sono trovate nell’impossibilità di poter far ricorso agli ammortizzatori sociali. O, nei migliori dei casi, non hanno potuto anticipare il pagamento a fine mese dei lavoratori, scaricando l’intero peso sull’Inps.
Il centro di Roma appare, ancora oggi, semi deserto. I turisti sono pochissimi, gli autobus che portavano lo comitive nella città eterna sembrano spariti. La fine della crisi non è dietro l’angolo. La capitale si trova di fronte ad una crisi forse senza precedenti. A meno di un anno dalle prossime elezioni comunali