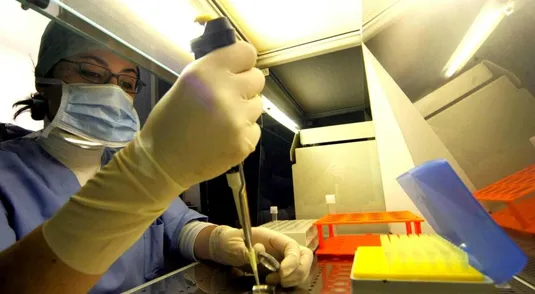Pizza, disciplina e Corano: a scuola per diventare buoni musulmani
Pizza, disciplina e Corano: a scuola per diventare buoni musulmani
Nella borgata di Tor Pignattara la scuola coranica Masjee ospita oltre 150 bambini, italiani di seconda generazione. Che studiano l'arabo e la disciplina, leggono i giornali e rafforzano quotidianamente il legame con le loro radici. “Quando sarò grande? I miei genitori mi presenteranno vari uomini e sceglierò tra loro il mio futuro marito” (Foto di Liana Bonanno)
Ascoltano in silenzio seduti per terra. Sui volti un sorriso tirato. Tra una manciata di minuti verranno chiamati dai loro esaminatori. Al centro della sala un bambino spiega le regole del buon musulmano. Agita le mani con fare divertito. Guarda i compagni e, rimbeccato, alza la voce. Mischia la lingua italiana a quella bengali. Poi appoggia l'indice su una parte del suo quadernino ed elenca: “Non portare il Corano in bagno”. E ancora: “Lavarsi mani, viso e orecchie prima di prendere il testo sacro in mano”. La lista, recitata meccanicamente ma con riverenza, continua fino all'arrivo di uno dei maestri. Fa cenno di abbassare la voce e le spiegazioni diventano sussurri.
Per arrivare alla scuola coranica Masjeed, la più grande di Roma con i suoi oltre 150 studenti, bisogna varcare la Casilina, muovere qualche passo sul lungo stradone che porta all'inizio di Tor Pignattara e svoltare in via Garbo Serbelloni. In questa borgata vivono diecimila musulmani. L'odore di spezie e caffè turco rimandano a un’altra terra. È il quartiere del melting pot, quello a sud est della capitale, dove a ogni angolo, più che in ogni altra zona di Roma, si incrociano i grandi banchi colorati dei fruttivendoli pakistani e i “bangla”, i tipici negozietti multietinici in cui si trova di tutto, a qualsiasi ora del giorno (e pure della notte).
[[ge:rep-locali:espresso:285289764]]
Ed è qui, all'ombra del Cupolone, all’incrocio tra il traffico della capitale e la vita del quartiere popolare, che sorge il centro culturale Masjeed. Ogni giorno un lungo serpentello di bambini entra al numero 25.
In Italia esistono 88 scuole coranica. C'è chi le descrive come luoghi di radicalizzazione, ma per capire cosa realmente siano, bisogna sedersi sui tappeti persiani e farsi assalire dai bambini che le frequentano, impazienti di raccontare e raccontarsi. “Studiamo inglese, bengali, le regole e impariamo a memoria il Corano”, dicono col sorriso sulle labbra e un pizzico di soddisfazione. E infatti parlano tutti almeno tre lingue correntemente e leggono perfettamente l’arabo.
La scuola è divisa in quattro classi. La fascia d'età e la conoscenza delle sacre scritture decretano il grado di appartenenza. Si parte dalla prima, quella dei più piccoli, che iniziano a frequentare la scuola a sei anni. L’ultima classe è composta, invece, da ragazzini che hanno piena padronanza del Corano. In mezzo, altre due classi in cui gli allievi alternano lettura e apprendimento mnemonico del testo. Gli allievi vanno al centro ogni giorni: dalle 17.30 alle 19.30 l'inverno, dopo la scuola; e dalle 10 alle 14 l'estate, eccezion fatta per il lunedì. Giorno in cui si godono un po' di libertà.
È l’imam Rahman Mizanur, responsabile del centro, barba nera e folta con qualche filo argentato, a spiegare che “l’Islam è un modo di vivere, è questo quello che insegniamo ai nostri studenti”. Le mani si muovono veloci mentre commenta la sua “idea di Islam”, mentre racconta la sua scuola. Incespica un po’ sull’italiano nonostante i 19 anni passati in Italia. Si riprende e va avanti illustrando con passione il suo lavoro, la sua missione di imam nel quartiere a più alta concentrazione di islamici di Roma. “Serve a dare loro una direzione - dice l’imam - Vogliamo evitare che prendano strade sbagliate. In tanti scelgono l’alcool, le droghe. Quello che facciamo qui è dare delle regole e insegnare ai ragazzi a rispettarle in modo da essere domani dei buoni musulmani”.
La formazione è importante. L'esigenza una sola: rimanere attaccati alle proprie radici. Ma questi bambini, i musulmani di seconda generazione, sono gli stessi che amano la pizza e gli spaghetti, che molto spesso hanno i genitori che lavorano in ristoranti romani o accudiscono anziani. Crescono legati alla loro cultura, pur dovendo fare le spese con una società, quella italiana, che chiede a loro di essere integrati. Una volta messo piede fuori dalla scuola coranica, dove si sentono protetti, quando si disperdono nei parchi di Roma, giocando a pallone o chiacchierando con gli altri bambini. Ed è questo il loro fragile equilibrio.
Nel vicolo, figlio dei palazzoni fatiscenti, appare un bambino di dieci anni. Abiti tradizionali, zainetto firmato Quechua. In testa porta la shiashia, il copricapo indossato dai musulmani. Si ferma davanti al portone di vetro. Entra e si perde nella penombra di una stanza lunghissima.
Togliersi le scarpe è obbligatorio prima di entrare nel grande stanzone coperto di tappeti della scuola coranica. Seduti per terra, quarantacinque bambini dai 9 ai 12 anni. Oggi è il giorno dell’esame estivo. Poi una breve pausa, prima di ricominciare con le lezioni di agosto.
Ripassano disciplinati. Attendono impazienti di essere chiamati e di sedere davanti agli esaminatori, dove rimarranno per trenta lunghi minuti.
Mentre scherzano, l'accento romano regna sovrano. Ma alla domanda sulla squadra del cuore, si scopre che nel centro Masjeed soffia vento bianconero. Idee chiarissima sul futuro: saranno medici o ingegneri. Due si lanciano in “piloti di aerei della marina”. Si vede che ancora conoscono poco la suddivisione dei comparti dell'esercito.
Aisha (nome di fantasia) ha 12 anni, legge i giornali e ha una visione chiarissima della vita. In questo suo mondo, fatto di scuola, amiche e normalità, si percepisce quanto le radici della sua cultura abbiano germogliato. “Quando sarò grande – spiega serissima – i miei genitori mi presenteranno vari uomini e sceglierò tra loro il mio futuro marito”. Ha un lungo velo che le copre i capelli. Al sussulto dei suoi interlocutori, aggiunge: “Fidanzarsi con più di un uomo non è una bella cosa”. Poi continua pacatamente: “Uno si deve sposare e non cambiare mai persona”.
Un uomo italiano, non islamico, non è neanche da prendere in considerazione e se le si fa notare che è ancora troppo giovane per poter avere una visione così netta della vita, fa cenno di no col capo e, prima di ammutolirsi, sussurra un “sarebbe troppo strano”. È sempre lei a spiegare che alla scuola coranica insegnano che Islam significa pace e che chi commette attentati “non rispetta le regole del Corano”.
Sin da piccolissimi vengono educati al rispetto, non solo degli spazi reciproci, ma anche della ferrea educazione. L'igiene personale è fondamentale. “Non salutare nessuno mentre ci si trova in bagno”, una regola inviolabile, così come “il non tenere il proprio smartphone sul tavolo”. Chi non le rispetta incorre in punizioni severe. Anche con un giunco. “Non ci fanno male, mica ce lo danno forte, e per alcuni è medicina santa”, esclama una di loro. Come se la pratica punitiva fosse assolutamente normale.
Vestono gli abiti tradizionali solo per Tor Pignattara, dove vive la comunità più grande della capitale, ma a scuola “preferiamo andare vestiti normali”, confidano sorridenti. Per le bambine niente velo: si va in jeans e maglietta. Al liceo si vedrà.
Sopra le panche si ammucchiano libri e quaderni. C'è chi oscilla avanti e indietro mentre recita cantilenando il Corano, imparato a memoria, senza conoscerne ancora a fondo la traduzione: “Alcuni lo imparano sia in arabo che in bengali, per ora noi impariamo solo alcuni passaggi, i più importanti, in arabo”.
In mezzo al mucchio, uno di loro non parla italiano. Sono gli altri compagni a tradurre per lui. Ammette di non andare a scuola. Dopo un faticoso dialogo, in cui in dieci forniscono varie versioni, offrendosi di aiutare a scoprire il perché di questa “cosa gravissima” - come ammettono stupiti con la mano davanti alla bocca - si scopre che studia a casa e torna spesso in Bangladesh. Almeno così sembrerebbe, anche se il dubbio rimane.
Per loro Dio “è buono”. Per loro Allah “non vuole questo”, dicono riferendosi agli attentati sanguinosi che straziano l’occidente in nome di un dio che non sembra essere il loro. Sembrano sapere perfettamente cosa accade nel mondo, nonostante trasudino innocenza.
Sul marciapiede, davanti al portone della Moschea, spiegano senza problemi che, superati i 12 anni, solitamente non festeggiano il compleanno. Poi, senza un motivo specifico, il discorso ricade sul Natale. Passa un uomo sui cinquant'anni, italiano, e guardando questi bambini di appena dieci anni, dice sprezzante: “Cosa cazzo ne sanno questi del Natale”. Poi prosegue per la sua strada. Si ferma poco più avanti. Si volta ancora e li guarda con sdegno. Loro abbassano lo sguardo. Fingono di non aver capito, colpevoli senza colpe. Un attimo. Una sola immagine. Un frammento di vita che prende forma su di un marciapiede. Lo stesso che percorrono ogni giorno per andare alla scuola coranica. Hanno dieci anni eppure, nonostante i discorsi infarciti da parole come integrazione o uguaglianza, loro, più di tutti, vivono spaccati a metà.
Per arrivare alla scuola coranica Masjeed, la più grande di Roma con i suoi oltre 150 studenti, bisogna varcare la Casilina, muovere qualche passo sul lungo stradone che porta all'inizio di Tor Pignattara e svoltare in via Garbo Serbelloni. In questa borgata vivono diecimila musulmani. L'odore di spezie e caffè turco rimandano a un’altra terra. È il quartiere del melting pot, quello a sud est della capitale, dove a ogni angolo, più che in ogni altra zona di Roma, si incrociano i grandi banchi colorati dei fruttivendoli pakistani e i “bangla”, i tipici negozietti multietinici in cui si trova di tutto, a qualsiasi ora del giorno (e pure della notte).
[[ge:rep-locali:espresso:285289764]]
Ed è qui, all'ombra del Cupolone, all’incrocio tra il traffico della capitale e la vita del quartiere popolare, che sorge il centro culturale Masjeed. Ogni giorno un lungo serpentello di bambini entra al numero 25.
In Italia esistono 88 scuole coranica. C'è chi le descrive come luoghi di radicalizzazione, ma per capire cosa realmente siano, bisogna sedersi sui tappeti persiani e farsi assalire dai bambini che le frequentano, impazienti di raccontare e raccontarsi. “Studiamo inglese, bengali, le regole e impariamo a memoria il Corano”, dicono col sorriso sulle labbra e un pizzico di soddisfazione. E infatti parlano tutti almeno tre lingue correntemente e leggono perfettamente l’arabo.
La scuola è divisa in quattro classi. La fascia d'età e la conoscenza delle sacre scritture decretano il grado di appartenenza. Si parte dalla prima, quella dei più piccoli, che iniziano a frequentare la scuola a sei anni. L’ultima classe è composta, invece, da ragazzini che hanno piena padronanza del Corano. In mezzo, altre due classi in cui gli allievi alternano lettura e apprendimento mnemonico del testo. Gli allievi vanno al centro ogni giorni: dalle 17.30 alle 19.30 l'inverno, dopo la scuola; e dalle 10 alle 14 l'estate, eccezion fatta per il lunedì. Giorno in cui si godono un po' di libertà.
È l’imam Rahman Mizanur, responsabile del centro, barba nera e folta con qualche filo argentato, a spiegare che “l’Islam è un modo di vivere, è questo quello che insegniamo ai nostri studenti”. Le mani si muovono veloci mentre commenta la sua “idea di Islam”, mentre racconta la sua scuola. Incespica un po’ sull’italiano nonostante i 19 anni passati in Italia. Si riprende e va avanti illustrando con passione il suo lavoro, la sua missione di imam nel quartiere a più alta concentrazione di islamici di Roma. “Serve a dare loro una direzione - dice l’imam - Vogliamo evitare che prendano strade sbagliate. In tanti scelgono l’alcool, le droghe. Quello che facciamo qui è dare delle regole e insegnare ai ragazzi a rispettarle in modo da essere domani dei buoni musulmani”.
La formazione è importante. L'esigenza una sola: rimanere attaccati alle proprie radici. Ma questi bambini, i musulmani di seconda generazione, sono gli stessi che amano la pizza e gli spaghetti, che molto spesso hanno i genitori che lavorano in ristoranti romani o accudiscono anziani. Crescono legati alla loro cultura, pur dovendo fare le spese con una società, quella italiana, che chiede a loro di essere integrati. Una volta messo piede fuori dalla scuola coranica, dove si sentono protetti, quando si disperdono nei parchi di Roma, giocando a pallone o chiacchierando con gli altri bambini. Ed è questo il loro fragile equilibrio.
Nel vicolo, figlio dei palazzoni fatiscenti, appare un bambino di dieci anni. Abiti tradizionali, zainetto firmato Quechua. In testa porta la shiashia, il copricapo indossato dai musulmani. Si ferma davanti al portone di vetro. Entra e si perde nella penombra di una stanza lunghissima.
Togliersi le scarpe è obbligatorio prima di entrare nel grande stanzone coperto di tappeti della scuola coranica. Seduti per terra, quarantacinque bambini dai 9 ai 12 anni. Oggi è il giorno dell’esame estivo. Poi una breve pausa, prima di ricominciare con le lezioni di agosto.
Ripassano disciplinati. Attendono impazienti di essere chiamati e di sedere davanti agli esaminatori, dove rimarranno per trenta lunghi minuti.
Mentre scherzano, l'accento romano regna sovrano. Ma alla domanda sulla squadra del cuore, si scopre che nel centro Masjeed soffia vento bianconero. Idee chiarissima sul futuro: saranno medici o ingegneri. Due si lanciano in “piloti di aerei della marina”. Si vede che ancora conoscono poco la suddivisione dei comparti dell'esercito.
Aisha (nome di fantasia) ha 12 anni, legge i giornali e ha una visione chiarissima della vita. In questo suo mondo, fatto di scuola, amiche e normalità, si percepisce quanto le radici della sua cultura abbiano germogliato. “Quando sarò grande – spiega serissima – i miei genitori mi presenteranno vari uomini e sceglierò tra loro il mio futuro marito”. Ha un lungo velo che le copre i capelli. Al sussulto dei suoi interlocutori, aggiunge: “Fidanzarsi con più di un uomo non è una bella cosa”. Poi continua pacatamente: “Uno si deve sposare e non cambiare mai persona”.
Un uomo italiano, non islamico, non è neanche da prendere in considerazione e se le si fa notare che è ancora troppo giovane per poter avere una visione così netta della vita, fa cenno di no col capo e, prima di ammutolirsi, sussurra un “sarebbe troppo strano”. È sempre lei a spiegare che alla scuola coranica insegnano che Islam significa pace e che chi commette attentati “non rispetta le regole del Corano”.
Sin da piccolissimi vengono educati al rispetto, non solo degli spazi reciproci, ma anche della ferrea educazione. L'igiene personale è fondamentale. “Non salutare nessuno mentre ci si trova in bagno”, una regola inviolabile, così come “il non tenere il proprio smartphone sul tavolo”. Chi non le rispetta incorre in punizioni severe. Anche con un giunco. “Non ci fanno male, mica ce lo danno forte, e per alcuni è medicina santa”, esclama una di loro. Come se la pratica punitiva fosse assolutamente normale.
Vestono gli abiti tradizionali solo per Tor Pignattara, dove vive la comunità più grande della capitale, ma a scuola “preferiamo andare vestiti normali”, confidano sorridenti. Per le bambine niente velo: si va in jeans e maglietta. Al liceo si vedrà.
Sopra le panche si ammucchiano libri e quaderni. C'è chi oscilla avanti e indietro mentre recita cantilenando il Corano, imparato a memoria, senza conoscerne ancora a fondo la traduzione: “Alcuni lo imparano sia in arabo che in bengali, per ora noi impariamo solo alcuni passaggi, i più importanti, in arabo”.
In mezzo al mucchio, uno di loro non parla italiano. Sono gli altri compagni a tradurre per lui. Ammette di non andare a scuola. Dopo un faticoso dialogo, in cui in dieci forniscono varie versioni, offrendosi di aiutare a scoprire il perché di questa “cosa gravissima” - come ammettono stupiti con la mano davanti alla bocca - si scopre che studia a casa e torna spesso in Bangladesh. Almeno così sembrerebbe, anche se il dubbio rimane.
Per loro Dio “è buono”. Per loro Allah “non vuole questo”, dicono riferendosi agli attentati sanguinosi che straziano l’occidente in nome di un dio che non sembra essere il loro. Sembrano sapere perfettamente cosa accade nel mondo, nonostante trasudino innocenza.
Sul marciapiede, davanti al portone della Moschea, spiegano senza problemi che, superati i 12 anni, solitamente non festeggiano il compleanno. Poi, senza un motivo specifico, il discorso ricade sul Natale. Passa un uomo sui cinquant'anni, italiano, e guardando questi bambini di appena dieci anni, dice sprezzante: “Cosa cazzo ne sanno questi del Natale”. Poi prosegue per la sua strada. Si ferma poco più avanti. Si volta ancora e li guarda con sdegno. Loro abbassano lo sguardo. Fingono di non aver capito, colpevoli senza colpe. Un attimo. Una sola immagine. Un frammento di vita che prende forma su di un marciapiede. Lo stesso che percorrono ogni giorno per andare alla scuola coranica. Hanno dieci anni eppure, nonostante i discorsi infarciti da parole come integrazione o uguaglianza, loro, più di tutti, vivono spaccati a metà.