
E l’Italia? Febbre gialla in arrivo anche da noi? Il contagio cinese spegnerà sul nascere la timida ripresa della prima metà dell’anno? “L’Espresso” lo ha chiesto a Andrea Goldstein, nuovo direttore di Nomisma, marchio tra i più prestigiosi della ricerca economica nel nostro Paese. Goldstein vanta una lunga esperienza all’estero in vari organismi internazionali e, tra l’altro, ha vissuto in Corea del Sud, dove ha studiato lo sviluppo e le contraddizioni di quell’area del mondo. «Se Pechino è nei guai, tutto il mondo rallenta e l’Italia soffrirà la sua parte», dice Goldstein. «Però», avverte il direttore di Nomisma, «va tenuto presente un fatto importante».
Quale?
«La crisi italiana deriva principalmente dalla stagnazione della domanda interna. Le famiglie non spendono, le imprese rimandano gli investimenti».
E quindi?
«Quindi per innescare la ripesa non basta l’aumento delle esportazioni, che vanno al traino della crescita globale. E infatti nei mesi scorsi abbiano visto che l’export, favorito dal calo dell’euro, è aumentato con effetti sul Pil positivi, ma solo marginali in termini assoluti».
Come se ne esce?
«L’unica via d’uscita è insistere sulle riforme che aumentano la produttività. Alcuni passi nella direzione giusta sono già stati fatti, penso per esempio al Jobs Act per quanto riguarda il mercato del lavoro. Si tratta di continuare in questa direzione, a cominciare dalla scuola».
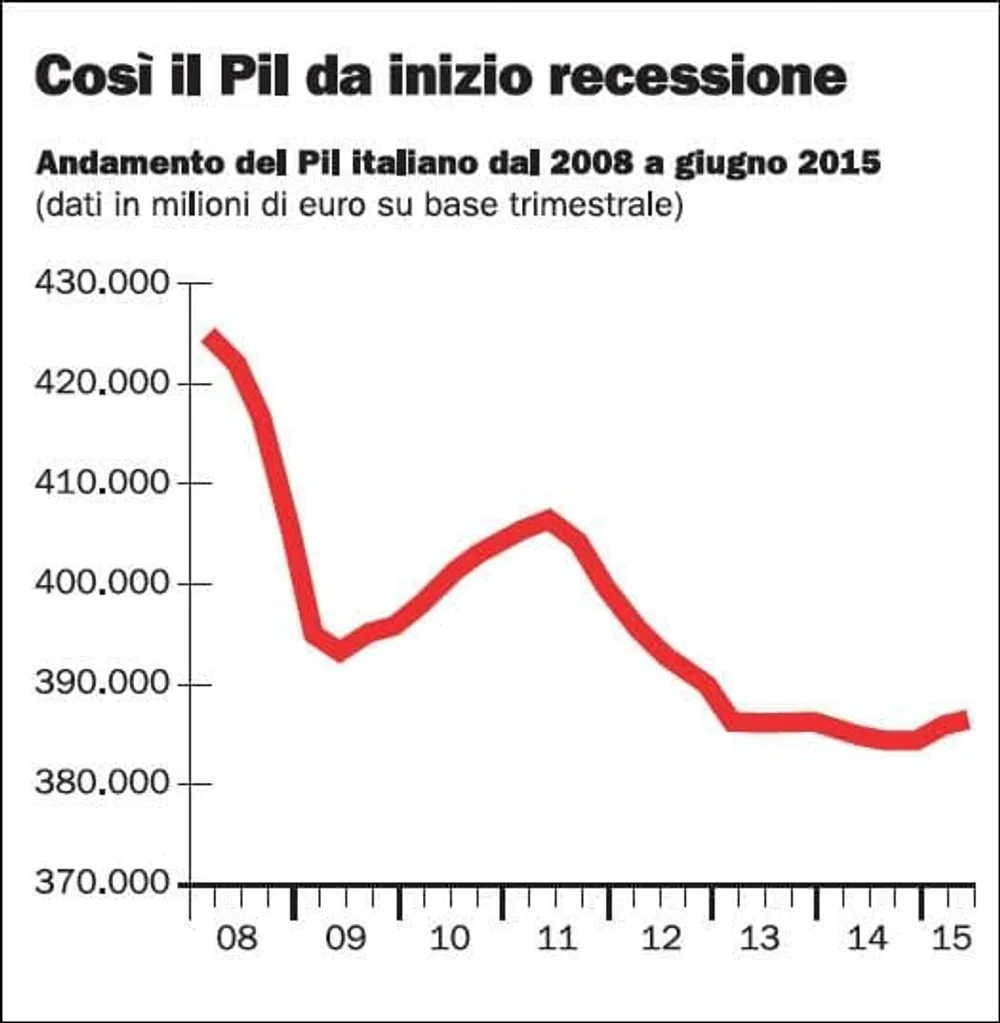
In un contesto internazionale che si fa più difficile, con un Pil che potrebbe crescere meno dello 0,7 per cento annuo previsto dal governo, anche i margini di manovra dell’esecutivo si restringono, non crede?
«Questo è vero, ma bisogna insistere con le riforme, non ci sono alternative. Del resto i problemi di fondo del nostro Paese si trascinano da oltre un ventennio, ben prima, quindi, della grande gelata della recessione. Giunti a questo punto, il prezzo da pagare all’immobilismo sarebbe davvero troppo alto».
Intanto però il crollo dei prezzi delle materie prime, a cominciare dal petrolio, si porta con sé nuovi rischi di deflazione.
«Non è una novità di questi giorni. Sono mesi che le materie prime perdono quota, in parte anche per effetto del rallentamento dell’economia della Cina, che è uno dei massimi compratori mondiali. I rischi di deflazione non sono quindi aumentati per effetto del recente terremoto finanziario a Pechino. Il quadro economico generale non mi sembra cambiato. Le gravi difficoltà di Paesi come Russia e Brasile, che sono anche esportatori di materie prime, sono le stesse di qualche mese fa».
Però in questi ultimi giorni anche l’euro sembra aver invertito la marcia e ha recuperato terreno sul dollaro. Un fatto piuttosto strano se si pensa ai problemi dell’area euro, dalla Grecia alla mancata crescita. Come lo spiega?
«È vero, la moneta unica ha guadagnato sulla valuta americana. E questo in teoria potrebbe creare qualche problema all’export. Credo però che si tratti di un fenomeno temporaneo che si spiega col fatto che sono ormai venute meno, almeno a giudizio di gran parte degli operatori, le attese di un imminente aumento dei tassi Usa. A questo punto non credo che la Fed intervenga a settembre, come era stato prospettato. E allora, se i tassi non aumentano, la quotazione del dollaro perde terreno».
Per quale motivo la Fed non toccherà i tassi?
«Nelle intenzioni delle autorità monetarie Usa la manovra al rialzo sui tassi doveva servire a raffreddare un’economia che si stava surriscaldando, con minacce di fiammate inflazionistiche. Questo scenario però mi sembra molto lontano dalla realtà di queste settimane. L’economia americana cresce meno del previsto e l’inflazione resta molto lontana da quella soglia del 2 per cento considerata ottimale dalla Fed».
Sta dicendo che anche il motore americano, dopo quello della Cina, è destinato a perdere colpi? Di questo passo addio ripresa, il mondo sembra destinato a precipitare in quella che l’ex segretario al Tesoro americano (presidenza Clinton) Summers ha definito una “stagnazione secolare”. Stiamo davvero correndo questo rischio?
«Il rischio concreto è che nessun grande Paese abbia la capacità, o la volontà politica, di attuare una politica espansiva in grado di trainare la crescita globale. Nel recente passato questo compito è stato svolto dagli Stati Uniti e, appunto dalla Cina, che però adesso non sembra più in grado di tenere il passo degli ultimi anni».
Come spiega il rallentamento di Pechino?
«La volontà del governo cinese è quella di agire in senso riformatore introducendo maggiori elementi di mercato in un’economia che è ancora fortemente regolata dal centro. Si cerca di spingere sui consumi interni e anche il credito bancario alle aziende, in massima parte a controllo statale, viene sorvegliato con maggiore attenzione rispetto al passato. La stessa manovra sulla moneta, lo yuan, che è stata svalutata a più riprese in agosto, può essere letta nel senso di dare un segnale all’esterno che anche il cambio in futuro sarà maggiormente esposto alla legge della domanda e dell’offerta».
E in questo contesto come si arriva ai crolli borsistici di questi giorni?
«La Borsa aveva corso moltissimo negli ultimi due anni. Basti pensare che anche dopo i pesanti ribassi dei giorni scorsi l’indice è ancora su livelli di oltre il 20 per cento superiori a quelli di ottobre 2014. La bolla doveva esplodere, prima o poi. E il crollo è stato amplificato dal fatto che molti acquisti erano stati fatti a leva, cioè, in sostanza, indebitandosi per comprare. Infine, un altro fattore negativo è la mancanza di fiducia da parte degli investitori, in massima parte cinesi, negli interventi del governo di Pechino. Pochi credono davvero che il regime, dopo avere a lungo soffiato sul fuoco del rialzo, ora sia in grado di far fronte alla situazione. E infatti le misure di sostegno degli ultimi giorni tradiscono il panico e vanno in senso opposto rispetto alle liberalizzazioni».
Quali sono i rischi per le imprese italiane che operano sul mercato cinese?
«Di sicuro i cinesi avranno meno soldi in tasca, anche quelli più ricchi. E questo peserà soprattutto sui conti dei grandi marchi del lusso».
E le aziende che esportano in Cina, a cominciare da quelle meccaniche?
«Va premesso che meno del 3 per cento dell’export complessivo italiano prende la strada della Cina. Detto questo, una volta esaurita la tempesta di questi giorni, se il sistema produttivo cinese riprenderà slancio grazie, tra l’altro, alla svalutazione dello yuan, allora si potranno aprire nuovi spazi di mercato anche per le aziende del Made in Italy, per esempio per la meccanica strumentale».




