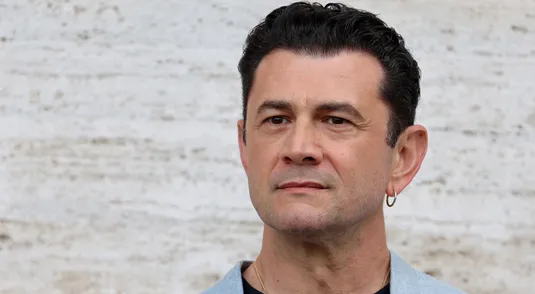Yasmina Reza: «Sono i dettagli la materia più esplosiva della nostra vita»
Incontro con la scrittrice francese, tra le più grandi autrici teatrali di oggi. «Mi sono sempre impegnata a fare una letteratura dei nervi»
Eccola, è tornata, Yasmina Reza. Adelphi ha pubblicato una nuova pièce, “Bella figura” (traduzione di Donatella Purturo) che è andata in scena per la prima volta nel 2017, allo Schaubühne di Berlino, diretta da Thomas Ostermeier, e nei nostri teatri diretta da Roberto Andò (con Simona Marchini, Anna Foglietta, Paolo Calabresi e David Sebasti).
Già l’incipit è decisivo: Boris porta Andrea, la sua amante, in un ristorante consigliato dalla moglie. E lei si irrita, vuole andarsene. Appena fanno marcia indietro, investono una vecchia signora, Yvonne – che si rivelerà l’eterna signora: non conta l’età, conta il carisma. Anche se chi lo possiede ha dimenticato tutto di sé. Peccato che Yvonne, venuta in quel ristorante a festeggiare il suo compleanno con la nuora e il figlio, sia la suocera della migliore amica della moglie di Boris. Ne uscirà un quintetto da camera molto divertente e molto elegante, mentre tutti perdono la loro eleganza. Ma l’umanità sgualcita dai desideri mancati non vale più di qualsiasi eleganza?
Yasmina Reza è una grandissima scrittrice. Forse qualcuno protesterà per l’aggettivo abusato. I superlativi irritano. Ma non si possono buttare aggettivi importanti solo perché vengono usati troppo, e male. Semmai vanno indagati. La grandezza di uno scrittore è come un abito su misura, anche se non si calcola con un metro e in centimetri vita: è un modo di stare nella letteratura, e di portarla. E ognuno ha la sua.
La grandezza di Yasmina Reza è il contrario di una grandezza, per esempio: è fatta di strettoie. Di curve al limite del precipizio, curve pericolose. Con lei si cammina sulla lama di un coltello. La gente si fa male, si taglia, ma la vita è così. Quindi, un piede davanti all’altro, si va. E i danni si calcoleranno dopo.
Basta chiacchierare un po’ con lei per capire quanto è intensa. Cerca sempre la verità, anche quando non la sa. Mai una risposta a effetto, per quanto donna di teatro. Se tu la interroghi, lei si interroga. Nulla è immediato, al di là dell’immediatezza dei suoi dialoghi teatrali. Perché la sua è un’immediatezza che si conquista, ragionando e sentendo le cose.
“Bella figura” è una pièce scritta nel 2015, fra “Felici i felici” e “Babilonia”, due opere in prosa. Anni fa, durante una nostra chiacchierata a Milano, mi ha raccontato che la sua formazione teatrale, molto tecnica, ha sempre condizionato la sua prosa. Vale anche il contrario? La sua scrittura in prosa ha influenzato in qualche modo la sua scrittura teatrale?
«In fondo, non ho mai riflettuto sull’interazione che potrebbe esserci tra questi due tipi di scrittura, poiché per me, appunto, non ci sono due tipi di scrittura ma due finalità diverse. Per esempio, io so in anticipo che un dialogo di teatro è finalizzato a essere detto ad alta voce e interpretato. Si pongono dunque immediatamente delle questioni di ritmo. Il dialogo del romanzo non risponde alle stesse leggi. Ma è abbastanza sottile. Sì, so quello che il teatro mi dà per la prosa: precisione, stringatezza e una temporalità limitata. Non saprei dire invece cosa la prosa mi ha dato per la scrittura teatrale. Devo rifletterci su…».
“Bella figura” è stata commissionata da Thomas Ostermeier per lo Schaubühne di Berlino e da lui diretta. Cosa succede in questi casi? Il rapporto con il regista e il teatro ne condiziona la genesi o no? L’ha scritta in totale indipendenza o si è confrontata con lui? L’ha scritta pensando agli attori o solo ai personaggi che aveva in mente?
«Ho incontrato Thomas a Berlino e mi ha chiesto se avessi voglia di scrivere un’opera per Nina Hoss di cui lui naturalmente avrebbe fatto la regia. Non avevo nessun altro vincolo, né riguardo al soggetto, né riguardo al numero dei personaggi e nemmeno sul loro genere. Solo un personaggio centrale dell’età di Nina. Da qualche parte, tra i miei appunti, avevo questa scena nel parcheggio che mi piaceva molto e mi sono detta che era l’occasione ideale per continuarla. Thomas non è intervenuto affatto nel mio lavoro ma gli ho mandato dei frammenti dell’opera mentre scrivevo».
Il tema della coppia e degli amori infelici è presente in tutta la sua opera. Leggendo “Bella figura” mi è venuta in mente una frase di “Felici i felici”: «Non puoi essere felice in amore se non hai un talento per la felicità». I suoi personaggi non ce l’hanno mai, questo talento. Ma forse è anche un bene – da un punto di vista narrativo, intendo – almeno restano dentro una tensione e fuori dall’ordinarietà (hanno anche parecchia paura dell’ordinarietà). Proprio stasera, mentre parlavo di lei, un’amica mi ha ricordato una frase di “Una desolazione”: «La vita è ciò che vogliamo con impazienza». In “Bella figura” gli impazienti soffrono, e i pazienti anche. Mi può descrivere questa impazienza per la vita?
«Mi fa piacere che lei abbia messo in evidenza queste due frasi. Spesso mi citano frasi tirate fuori direttamente dai miei libri, che sono solo il riflesso dell’umore dei personaggi e non mi corrispondono. Queste due frasi, potrei averle dette io. Dal punto di vista della scrittura, la disposizione alla felicità di un personaggio, non è per me la più propizia. Ma ho creato dei personaggi che l’avevano e che mi piacciono molto: Genevieve in “Una desolazione” o la donna ne “L’uomo del destino”. Nella vita… penso che sia una qualità e una fortuna. Purché questa disposizione non sia dovuta a un carattere futile. Potremmo anche dire, più modestamente, disposizione alla gioia».
Desideri e paure cambiano con il tempo. La malinconia, che poi è il sentimento del tempo, è centrale nel suo lavoro. Mi ha molto colpita la battuta finale di “Bella figura”, che riassume qualcosa di più di una commedia, direi la sua opera intera: «Ti immagini che l’esercito avanzi, e invece sei lì che sfiorisci». Penso alle gambe di Andrea e ai suoi tacchi alti e insieme a Yvonne che crolla sotto una macchina o su un divano, ma solo per seppellire tutti. Possiamo parlare dell’invecchiamento? È solo rovina o la rovina comincia altrove?
«Non so parlare, al di fuori della scrittura, dei soggetti che tratto. Ho l’impressione di dare una versione semplicistica e banale di quello che mi sono sforzata di far sentire e provare. Ai miei occhi “Bella figura” non è una commedia. Naturalmente ci sono molti aspetti comici ma il fondo è triste. L’usura delle cose, delle relazioni, la sensazione di essere in esilio… Quest’ultima sensazione riguarda se stessi. Tutto quello che si sbaglia, che non si fa o che si fa inutilmente, come l’acquisto insensato delle scarpe con i tacchi alti…».
Nelle sue opere, teatrali e in prosa, c’è sempre un evento piccolo che scatena tutto. È quasi una firma sua. Penso a “Carnage”, e a tutti i suoi racconti. Persino in “Babilonia” l’evento terribile è provocato da un niente. Ma le coincidenze non sono mai un espediente narrativo, sembra più la vita – fatta così. Provocata da un niente, appunto. Da dove nasce questo attaccamento per l’evento minimo che si trasforma in un uragano? Dall’osservazione della vita? Da un ricordo?
«Le nostre giornate sono fatte di inezie: impazienza, piccoli obblighi, spostamenti, attese deluse, screzi… È questa la materia delle nostre vite. Ed è una materia esplosiva, appunto perché insoddisfacente. Lontana dalle idee di spazio e grandezza che i miti ci propongono. Questo essere ridotti a noi stessi è una sfida per i nervi. Mi sono sempre impegnata a fare una letteratura dei nervi».
Altro tema – molto Reza – sono gli oggetti. Ho ritrovato il phon di “Carnage” in “Bella figura”. Penso all’agenda di Yvonne, che è il perno della sua vita anche se non se la ricorda più. Perché gli oggetti si impadroniscono di noi e ci definiscono? Non sono solo espedienti teatrali o narrativi, sono una parte ingombrante della nostra esistenza. Quale rivelazione portano? Quale cattivo o necessario messaggio?
«Come non parlare degli oggetti? Sono ovunque e noi abbiamo con loro un rapporto passionale. C’è una poesia magnifica di Borges che s’intitola “Le cose”. Enumera tutte le cose che l’accompagnano e termina così : «Dureranno più in là del nostro oblio, non sapran mai che ce ne siamo andati». Vedo un aspetto straziante e esistenziale nella vita delle cose che ci circondano. Sono loro che fanno per noi le veci del Tempo».
In “Bella figura” ho trovato un altro tema: il senso dell’abbandono. Sfugge appena, come un lamento di Andrea e di Françoise, eppure pesa. Di colpo ho sentito che era importante e mi sono ricordata che in fondo è presente in tutta la sua opera e che io l’avevo sempre sottovalutato. Cosa abbandoniamo? Perché abbandoniamo e ci sentiamo abbandonati? Perché ci distrugge questo sentimento? Perché non sappiamo affrontarlo?
«Mi piacerebbe poter rispondere alle sue ultime domande ma non posso. Per ignoranza. E per incapacità. Ma è vero che la questione dell’abbandono è centrale».
Un giorno lei mi ha raccontato che parla da sola per strada. Che le vengono in mente le battute mentre cammina e la gente la prende per matta. Lo fa ancora? Che rapporto c’è fra il movimento e le voci che sente?
«Mi piace camminare. A molti scrittori piace camminare, no? Camminare irriga e scioglie il cervello. Non credo che quella dello scrittore seduto alla scrivania sia una buona posizione. Anche il corpo deve scrivere. Il corpo capisce meglio del cervello le inquadrature, i colori, il ritmo».
L’ultima volta che ci siamo viste, alcuni anni fa, mi ha raccontato che aveva preso una casa a Venezia. Ci sta bene? Le piace? Che rapporto ha con l’Italia e l’italiano? Le sembra cambiata, l’Italia?
«Sì, l’ho comprata! E ho imparato l’italiano. Non parlo ancora bene ma ci provo con grande piacere. Mi piace molto il vostro paese che mi sembra ancora più pazzo del nostro ma forse con un senso della fatalità più dolce».